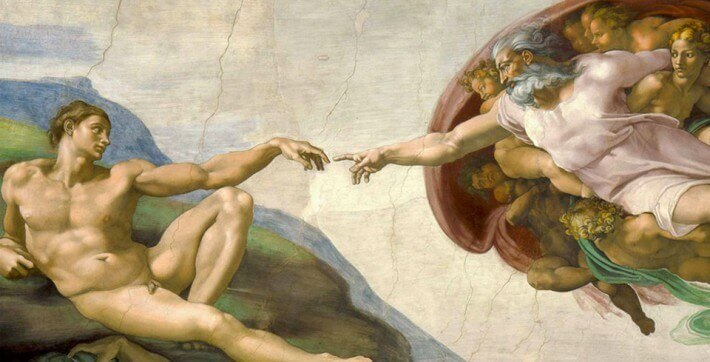Le Dichiarazioni universali dei diritti umani sono state sancite per
la prima volta con la Rivoluzione americana, poi con quella francese;
l’ultima è la rielaborazione delle Nazioni Unite del 1948 e, per
l’Unione europea, il riferimento è la CEDU (Convenzione Europea dei
Diritti dell’Uomo). Questi sono alla base del costituzionalismo e degli
ordinamenti giuridici occidentali. Alla luce della contemporaneità
questi diritti sono ancora il collante per la tenuta morale e sociale
dei cittadini oppure la Carta dei diritti rimane solo un vacuo
riferimento carico di significato retorico senza più basi reali e
sostanziali?

Qual è il fondamento di queste carte dei diritti?
La base è il contrattualismo. La base su cui si sono fondati i
diritti dell’uomo non è stata la natura oggettiva dell’essere umano,
bensì il consenso dei consociati: solo attraverso l’accordo comune si
creano i diritti fondamentali. Da un momento storico preciso, che è la
Rivoluzione francese, si è posta l’utopia ideologica come ordinamento
sopra una realtà oggettiva che preesiste a qualsiasi valutazione umana.
Quello che si è fatto è stato mettere sul tavolo ex novo una
serie di diritti, i quali, senza un vincolo a un dato oggettivo come un
vincolo di dovere morale reciproco tra gli individui, potranno essere
spazzati via facilmente. Se è l’accordo a far nascere i diritti, potrà
essere sempre un accordo contrario a farli morire oppure una decisione
diversa che, a proprio piacimento, può dare un significato diverso ad
ognuno di di essi, per cui nessuno può escludere l’idea di far nascere
nuovi diritti sulla base dell’astrattezza decisionale dei singoli. Chi
ha, dunque, il diritto di vietare nuovi diritti?
Le democrazie moderne dotate di una Carta costituzionale sanciscono
delle libertà (libertà fondamentali o principi fondamentali) che
traggono la loro legittimità esclusivamente dalla coesistenza
all’interno della società di valori condivisi: la costituzione italiana è
frutto di un compromesso da cui si sono formalizzati i principi
fondanti della nuova Repubblica democratica. La Carta costituzionale è
appunto una carta; chi dà significato alle parole scritte sono gli
uomini che l’hanno redatta: una tale Costituzione non può avere valore
assoluto.
La validità di determinati principi si fonda sull’opinione
maggioritaria (o, comunque, ritenuta “generale”) della bontà e
dell’utilità di questi principi oppure vi è un valore oggettivo
intrinseco di tali principi?
In altre parole, una Carta costituzionale o una legge è sufficiente
che sia approvata a maggioranza da un’Assemblea costituente o da un
Parlamento nel rispetto delle procedure tecniche oppure, per essere
considerata giusta e rispettabile dovrebbero essere presi in
considerazione anche argomenti sostanziali, perfino di natura
metafisica? È un problema di legittimità e validità.
Un ulteriore problema riguarda le modalità con cui vengono fatti
rispettare questi principi, se una minoranza decide deliberatamente di
non aderirvi. Se non sono assoluti, lo Stato dovrebbe assumersi
l’obbligo di far obbedire i cittadini a quei principi che lo stesso
Stato ha fondato, e questo ci ricondurrebbe allo Stato etico che tanto
si cerca di osteggiare.
Lo Stato liberale per la sua laicità costitutiva, non possiede i
presupposti spirituali e valoriali, non può e non sarebbe in grado di
guidare i cittadini attraverso i mezzi della coercizione giuridica e del
comando autoritativo, se non rinunciando alla propria liberalità,
ricadendo così in quel totalitarismo da cui aveva cercato di svincolarsi
dopo la caduta dei regimi anche solo autoritari.
La conclusione che si prende valida è quella suggerita dal paradosso di Böckenförde: lo Stato liberale secolarizzato non può garantire i diritti sanciti nella sua Costituzione.
«Lo Stato liberale secolarizzato vive di presupposti che non è in
grado di garantire. Questo è il grande rischio che esso si è assunto
per amore della libertà»[1].
In realtà la laicità e la neutralità dello Stato non coincidono mai con l’assenza di principi.
Fintanto che lo Stato liberal-democratico al suo interno avrà una
coesione morale e sociale dei suoi cittadini, tenuti insieme dai
cosiddetti corpi intermedi, questo si terrà in vita, quando, invece,
tutto questo incomincerà a mancare, si cercherà di riportare un nuovo
collante che si fonderà sulla promessa di una utopia sociale di felicità
e benessere. E, infine, se verrà a mancare anche il benessere come si
manterrà questo Stato? Qui veniamo al punto. L’ordinamento in cui
viviamo è disgregante, perché è relativista, soggettivista e
individualista. Il benessere e la stabilità economica, tanto evidenti
durante gli anni ‘60 e ‘70, poi ancora pressoché mantenuti negli anni a
venire, sono stati messi in crisi nel XXI secolo.
Su quali basi può continuare a reggersi lo Stato? E quali diritti
dovranno essere efficacemente garantiti? In realtà, come suggerito
prima, lo Stato è fondato su dei principi. Anche se la società attuale è
disgregante, non è del tutto esatto dire che sia assente un piano
valoriale, ma vi subentra l’utopia ideologica che impone nuovi paradigmi
valoriali. Questa è una questione fondamentale, alla quale corrisponde,
inoltre, l’eterna lotta tra quelle che sono le filosofie del diritto
dominanti, ovvero giusnaturalismo e giuspositivismo. Un ulteriore
problema si pone nel differenziare la filosofia giusnaturalista
classica, avente origine dalla filosofia greca, in particolare quella
aristotelica, e dal diritto romano, purificati ed esaltati dalla morale
cristiana e dalla filosofia tomista, ed il giusnaturalismo moderno, a
partire da Ugo Grozio (1583-1645), Thomas Hobbes (1588-1679), Samuel von
Pufendorf (1632-1694), John Locke (1632-1704), Jean-Jacques Rousseau
(1712-1778) e Immanuel Kant (1724-1804). La differenza fondamentale tra
queste posizioni è che i teorici moderni del diritto naturale, al
contrario di quelli medievali, hanno voluto svincolarsi da concezioni
teologiche e religiose, esprimendo, con l’elemento natura, la negazione
di ogni ordine ontologico precostituito di origine divina, con
l’affermazione della libera soggettività umana quale unica fonte del
diritto.

Ambrogio Lorenzetti (1290-1348), Allegoria del Buon Governo (1338-1339)
Che fondamento hanno, dunque, le basi morali su cui si fonda il diritto naturale?
La tesi moderna maggioritaria fa coincidere la base morale con le
espressioni e percezioni soggettive della nostra mente che, a livello
generale, riproducono una convenzione sociale. Vizio e virtù non sono,
quindi, aspetti intrinseci del fatto, ma fattori estrinseci ad esso e
presenti solo nell’intelletto del soggetto, il quale, poi,
arbitrariamente li trasferirà sul fatto stesso. È la separazione tra «ciò che è» e «ciò che deve essere»,
divisione tra prescrizione e descrizione, tra fatto e valore del fatto,
ci stiamo riferendo alla cosiddetta «legge di Hume». È la separazione
del mondo fisico-empirico dalla metafisica. Se sono separati e se si fa
attribuire al mondo empirico l’oggettività e a quello metafisico la
soggettività, ossia l’opinabilità, si conclude che le norme morali non
hanno un fondamento oggettivo.
La tesi contraria, ed è quella che si sostiene, è che le norme morali derivano dalla descrizione della natura umana (dall’essentia entis, cioè dall’osservazione della realtà delle cose) che attraverso la ratio si
trasformerebbe in norma etica. La conoscenza dell’essenza dell’uomo
porta a conoscere i suoi fini, dunque i suoi doveri: l’essere
automaticamente si proietta verso il dover essere. In altre parole, non è
la volontà arbitraria dell’uomo a stabilire i suoi fini, ma è la sua
stessa natura che l’uomo può razionalmente comprendere e successivamente
può volontariamente mettere in azione (o anche non mettere) in
conformità ai fini. La realtà oggettiva delle cose presuppone un ordine
metafisico che ordina il mondo fisico, dunque anche l’uomo. Se nelle
creature irrazionali esiste un ordine di natura fisico-chimico, nelle
creature razionali si esprime nella legge morale divina. Ogni essere
umano sperimenta una tensione verso l’assoluto, la conoscenza e la
verità. Da qui proviene anche la qualità specifica dell’essere umano
come essere sociale volto alla cooperazione con gli altri esseri umani
per il bene comune.
Il bene e il male sono categorie
concettuali comprensibili con il retto uso della ragione, non si basano
su presupposti soggettivi: possono anche essere intuizioni colte dagli
stati d’animo, dalle emozioni e dai sentimenti, ma la comprensione e la
verifica avviene tramite un atto di ragione ed un atto di Fede che si
può razionalmente comprendere. È l’accordo assoluto tra Fede e ragione,
dove la prima è ampliamento ed approfondimento della seconda: la persona
di Fede è più profondamente ragionevole di chi ne è privo, anche in
campo etico e politico-giuridico, perché, giova ricordarlo, la politica,
di cui il diritto è elemento eminente, è parte dell’etica, che, a sua
volta, discende dalla metafisica.
Se l’istintività nella morale viene fatta passare come genuina, un
agire che asseconda le nostre pulsioni e morbidezze d’animo
(irrazionali) sarà erroneamente percepito come buono e giusto. Ci sono
istinti razionalmente comprensibili come, ad esempio, la conservazione
della vita, per cui appunto si obbedisce al comandamento «non uccidere».
È sicuramente contraddittoria la considerazione di Hobbes: «fintanto
che gli uomini vivono nello stato di natura bene e male sono solo nomi,
solo nomi che significano i nostri appetiti e le nostre avversioni»[2].
Lo stato di natura prefigurato da Hobbes è uno stato di bestialità,
contrariamente a quello di Rousseau, che considera questa natura come
perfetta, pienamente genuina, assente di peccato originale. Su queste
due concezioni opposte dello stato di natura si fonda ideologicamente
ogni teoria politica moderna. Dall’Essere ciò che si deve Essere si è
passati dall’Essere ciò che piace o, come direbbe Hobbes, ciò che piace
al sovrano, dunque al potere politico costituito. Per Rousseau bisogna
Essere ciò che utopicamente si crede l’Essere. Entrambe le
considerazioni sono assurde e irrazionali, perché non sono reali. L’uomo
non è una bestia, ma non è neanche un essere perfetto.
È il fallimento del razionalismo; proprio l’Illuminismo, con il suo
mito razionalista e la sua pretesa rivoluzionaria, ha condotto al
rovesciamento dei suoi presunti fondamenti.
Uno di questi fondamenti è il relativismo secondo cui la verità
morale non esiste, ma esistono più verità (è uso comune affermare: «non
ci sono fatti, ma solo interpretazioni», vale a dire «la tua idea vale
quanto la mia») e come tali devono essere chiamate opinioni. Tutte le
opinioni hanno diritto di essere espresse, tranne quella che afferma che
la verità sull’uomo c’è ed è conoscibile a noi. Segue questo filone il
soggettivismo. Se non vi è una verità, ogni persona ha la sua verità e
così anche la sua morale, solo così si possono elevare a diritto i
desideri, i vizi e i piaceri di ciascuno e via via riconoscere come beni
pubblici le verità dei singoli.

Abraham Bosse (1604-1676), incisione del Frontespizio del Leviatano di Thomas Hobbes (1651)
I desideri allora diventano assoluti, perché svincolati da un dato
oggettivo, che li possa giudicare; insindacabili, perché l’autore ultimo
delle verità morali è l’uomo stesso. Per l’uomo post-moderno è
“eretico” affermare che la verità morale e la legge naturale siano
qualcosa di inscritto nel cuore degli uomini, nella loro stessa natura,
da un’entità divina superiore alla materialità umana, ma che può essere
razionalmente compresa e a cui ci si può adeguare.
Vi è poi l’ideale democratico, secondo lo spirito di Rousseau: la
“verità” va messa ai voti e sarà la maggioranza a stabilire ciò che è
meglio per tutti. Se è la maggioranza ad avere in mano la verità, o
forse così è bene farglielo credere, poi poco importa se il popolo oggi
sia facilmente manovrabile nei suoi orientamenti e nelle sue
convinzioni, allora anche chi lo rappresenta non potrà che varare leggi
giuste e condivise. In questo vi è una menzogna più o meno velata,
perché sempre di più molte leggi sui principi non negoziabili sono
frutto di un’oligarchia tecnocratica, le cui idee non sono certo quelle
della base popolare.
Non di meno è opinione comune considerare che se un comportamento è
diffuso, questo allora è normale, se è normale è buono, se è buono deve
essere legittimato. È un aspetto fenomenologico che ha decisamente
origine da quel filone positivista ottocentesco, dove è la prassi che
indica la direzione da seguire. Dall’affermare che è normale ciò che è
diffuso, il passo è breve per affermare come norma anche l’eccezione che
socialmente può diventare diffusa (il caso particolare che fa saltare
la regola generale; in ciò il pensiero radicale ha fatto scuola).
La morale diventa un’enorme fabbrica che produce in continuazione
desideri, sogni e utopie. Negli ultimi anni tale fabbrica produce così
tanto e velocemente che il diritto fa fatica a stare al passo con le sue
leggi, ma questo è logico, perché il diritto è frutto di un artificio
che risiede nella volontà arbitraria dell’ideologia politica. Il diritto
di oggi non si trova più nel Corpus iuris, nella scienza
giuridica, nelle consuetudini della nazione, bensì nelle pieghe del
pastrano dei nostri legislatori. E siamo ben oltre, perché le leggi non
le detta neanche più il Parlamento.
Avendo delineato a livello molto generale le basi del pensiero
moderno che condiziona il nostro ordinamento giuridico, c’è da
domandarsi se alla luce della complessità della nostra contemporaneità,
sia ancora lecito appellarsi ai presunti «diritti dell’uomo».
La conclusione che se ne trae è che l’uomo occidentale, inebriato
dalla cultura liberale e soggettivista e da un vero e proprio dogma dei
diritti umani, in realtà ha smarrito se stesso. Ha rinunciato a vivere e
persegue delle chimere. Il sogno americano della «ricerca della felicità» si è infranto. «L’uomo
veramente felice persegue la realizzazione di stati d’essere, non di
stati emotivi, vuole vivere in un mondo reale e non solo vivere le
impressioni appaganti che potrebbero venire da quello. Il piacere
sganciato dal dato reale è menzognero perché si richiama ad una realtà
che non c’è»[3].
Il diritto naturale ci obbliga ad essere. Un obbligo che non è fine a
se stesso, come avrebbe inteso Kant: devi perché devi. Un obbligo che
non nasce neppure da un capriccio di Dio e della Chiesa cattolica. Un
obbligo che è invece preludio di felicità. La strada del bene e della
felicità è già indicata nella nostra natura.
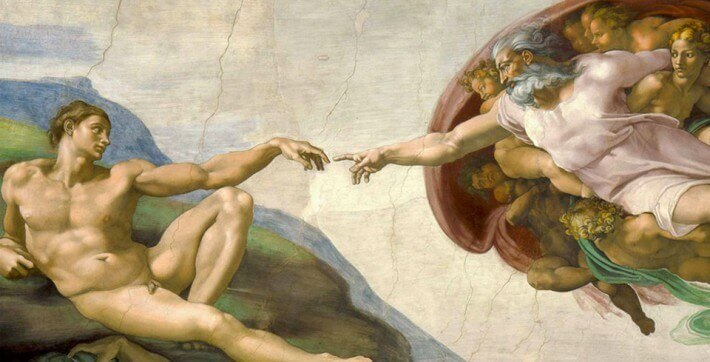
1 Ernst-Wolfgang Böckenförde, Diritto e secolarizzazione: dallo Stato moderno all’Europa unita, Laterza, 2007 – pp. 226. L’Autore è un ex giudice della Corte Costituzionale tedesca, docente di diritto costituzionale e filosofia del diritto.
2 Thomas Hobbes, Leviatano, capitolo XV.
3 T. Scandroglio, La teoria neoclassica sulla legge naturale di Germain Grisez e John Finnis, G. Giappichelli Editore, Torino 2012.
Dalle «Catechesi» di san Cirillo di Gerusalemme, vescovo (Catech. 18, 23-25; PG 33, 1043-1047)
La Chiesa, cioè l`assemblea del popolo di Dio
La Chiesa senza dubbio è detta cattolica, cioè universale, per il fatto
che è diffusa ovunque dall`uno all`altro dei confini della terra, e
perché universalmente e senza defezione insegna tutti i dogmi che devono
giungere a conoscenza degli uomini, sia riguardo alle cose celesti, che
alle terrestri. La Chiesa si dice cattolica anche perché è destinata a
condurre tutto il genere umano, autorità e sudditi, dotti e ignoranti,
al giusto culto. E` cattolica, infine, perché cura e risana ogni genere
di peccati che si compiono per mezzo dell`anima e del corpo. Essa poi
possiede ogni genere di santità dell`agire, del parlare e anche quella
dei carismi più diversi. Con termine molto appropriato essa si chiama
Chiesa, vale a dire assemblea convocata, poiché riunisce tutti e li
raccoglie in unità, come dice il Signore nel Levitico: E convoca tutta
l`assemblea davanti alla porta del convegno (cfr. Lv 8, 3). E`
certamente cosa degna di nota che questo termine «convoca» sia adoperato
per la prima volta nella Scrittura proprio in questo passo, dove si
legge che il Signore costituisce Aronne sommo sacerdote. E nel
Deuteronomio Dio dice a Mosé: Convoca il popolo, e io farò loro udire le
mie parole, perché imparino a temermi (cfr. Dt 4, 10). Del nome chiesa
fa pure nuovamente menzione quando, riguardo alle tavole, dice: E in
esse vi erano scritte tutte le parole che il Signore aveva promulgato
per voi sul monte, in mezzo al fuoco, nel giorno della chiesa (cfr. Dt
10, 4), cioè dell`assemblea convocata, come se dicesse più apertamente:
«Nel giorno in cui, chiamati dal Signore, siete stati riuniti». Anche il
salmista dice: «Ti loderò, Signore, nella grande assemblea, ti
celebrerò in mezzo a un popolo numeroso» (Sal 34, 18). Prima il salmista
aveva già cantato: «Benedite Dio nelle vostre assemblee, benedite il
Signore, voi della stirpe di Israele» (Sal 67, 27). Dalle genti il
Salvatore edificò una seconda santa Chiesa, la nostra di cristiani,
riguardo alla quale disse a Pietro: «E su questa pietra edificherò la
mia Chiesa, e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa» (Mt
16, 18). Ripudiata infatti quella chiesa, che era l`unica ad esistere in
Giudea, in seguito per tutto il mondo si moltiplicano le chiese di
Cristo, delle quali è stato detto nei salmi: «Cantate al Signore un
canto nuovo, la sua lode nell`assemblea dei fedeli» (Sal 149, 1). A
questi Giudei il profeta si rivolse con espressioni consimili: «Io non
mi compiaccio di voi, dice il Signore degli eserciti», e subito
soggiunge: «Per questo dall`oriente all`occidente grande è il mio nome
fra le genti» (Ml 1, 10-11). A riguardo di questa stessa santa Chiesa
cattolica, scrive Paolo a Timoteo: «Perché tu sappia come comportarti
nella casa di Dio, che è la Chiesa del Dio vivente, colonna e sostegno
della verità» (1 Tm 3, 14).

.png)